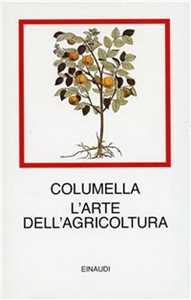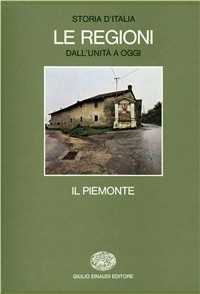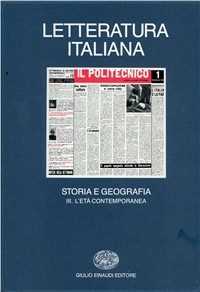Sfoglia il Catalogo Feltrinelli3
<<<- Torna al MenuCatalogo
Mostrati 123041-123060 di 124642 Articoli:
-
L' istruttoria. Oratorio in undici canti

"L'inferno del maggiore Lager, del Lager per antonomasia è disegnato nella sua estensione e profondità, le sue istallazioni descritte con rigore catastale, l'iter del detenuto minuziosamente tracciato, dalla sosta sulla banchina ferroviaria al forno crematorio. Ma il passato è solo una delle dimensioni dell'oratorio di Weiss: l'altra, meno avvertibile per la sua stessa mobilità e ambiguità, è quella del presente, del modo in cui quel passato è rivissuto, atteggiato. All'evocazione dei fatti compiuta dagli scampati, corrispondono le interpretazioni, le prese di posizione degli imputati e di molti «testimoni», che depongono a piede libero. Questo aspetto dell'Istruttoria, se anche meno emozionante, ha una forza di rivelazione, anzi di denuncia, stupefacente".
EUR 14.72
-
I blues

I personaggi e, ancora più spesso, le protagoniste di Tennesee Williams, sono individui costretti a “compensare alle crudeli deficienze della realtà con l'esercizio di un po' di immaginazione”. La necessità di un'illusione, cioè la follia, nasce negli insoddisfatti, nei delusi, in coloro che la vita ha privato di un unico bene e, travolgendo l'equilibrio morale, stabilisce una nuova tensione di desiderio, istintivo, animale, febbrile. La poetica di Williams si propone di riprodurre e, quando si può, rivelare la verità misteriosa, resuscitandola con cechoviana minuzia allusiva di particolari e contrappunti di musiche. La sua atmosfera teatrale carica di rumori, suoni, echi lontani, è già in sé un tentativo di fare concerto, di far rimbalzare ogni parola contro un muro sonoro.
EUR 9.50
-
Le fiabe

Andersen, viaggiatore instancabile, ospite delle corti europee, dei nobili castelli danesi, uccello migratore mai sazio di becchime esotico, si nutrì di tutte le letterature e di tutti i paesaggi, e tuttavia , pur tra le sue molte peregrinazioni, è tutt'altro che un "déraciné". Rivivono nei suoi libri i vari aspetti dei paesi da lui visitati: la Spagna, l'Italia la Svizzera, la Scozia, l'Oriente; ma le radici della sua poesia sono nella terra danese, egli è forse il più danese di tutti gli scrittori. In fondo al cuore egli serberà sempre il mondo della sua infanzia: l'immagine della madre povera, il piccolo giardino di cipolle e prezzemolo sul tetto che vediamo rifiorire nella Regina della neve. Negli ambienti aristocratici che la celebrità gli dischiuse, non si scordò mai delle proprie origini popolane, e pur essendo un assiduo lettore della favolistica mondiale, fonte di tutta la sua poesia restò sempre quel mondo fantastico che gli si rivelò quando, bambino, ascoltava, nelle lunghe veglie, i racconti della povera gente. La grandezza e l'originalità di Andersen derivano in gran parte dalla sua fede; in quel mondo di fantasmi che esprimono gli spaventi e le speranze della vita, lui, come la semplice gente del popolo, crede e crea. Prefazione di Knud Ferlov, con trenta tavole di illustrazioni di bambini di tutto il mondo. Età di lettura: da 10 anni.
EUR 80.75
-
Antiche fiabe russe

L'uccello di fuoco e la principessa Vassilissa, Il vampiro, L'anello magico, Storie di streghe, La montagna d'oro: sono alcune delle fiabe raccolte in questo volume. Esse nascono da una estrema varietà di motivi ispiratori. Dalle imprese che principi valorosi devono superare per liberare principesse prigioniere, alle vicissitudini di belle fanciulle perseguitate da matrigne; dagli impicci in cui si cacciano i contadini tonti alle astuzie delle bestie parlanti, dei lupi e dei cavalli fatati, passano in rassegna le mille forme in cui nei secoli si è espressa la fantasia popolare slava. I principi sono qui figli di zar, la campagna è l'immensa pianura russa, i palazzi hanno cuspidi splendenti, tutto ha il sapore di una favolosa terra lontana.
EUR 76.00
-
Don Chisciotte della Mancia

«La piú gran satira umana contro l'umano entusiasmo» Giosuè CarducciLa traduzione del Don Chisciotte che Vittorio Bodini, appassionato ispanista e poeta, realizzò per i Millenni Einaudi nel 1957 è considerata un modello di limpidezza, per la linearità con cui restituisce il lucido smalto alla prosa di Cervantes, e al tempo stesso di arguzia, per la resa esemplare di bisticci, battute e proverbi.
EUR 90.25
-
Fiabe del focolare
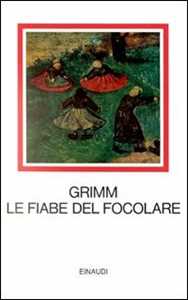
Pubblicate per la prima volta tra il 1812 e il 1822, le fiabe dei Grimm, filologi e studiosi di folclore, sono rapidamente diventate un autentico classico della letteratura e della cultura. Il monumento che i Grimm volevano dedicare con la loro opera alla poesia popolare, ad una tradizione nazionale che aveva le sue radici nel Medioevo, non era inizialmente destinato ad essere un libro per ragazzi. Ma già Goethe scriveva alla Stein che era fatto “per rendere felici i fanciulli”: e così è stato, per generazioni e generazioni, sino ai nostri giorni.Questo volume, che ha costituito la prima edizione italiana completa delle celebri fiabe, ne offre una traduzione che serba intatta la fresca vena popolare e la semplicità primitiva del testo originale. Accanto a Biancaneve, Cenerentola, Pollicino, Cappuccetto Rosso, Barbablù, ecco nuovi personaggi, nuovi incantesimi ed eroiche imprese. A chiunque, in un qualsiasi bosco o villaggio, può succedere di incontrare una strega o una fata, e subire strane metamorfosi, o vivere una grande avventura. Ogni rivo, ogni filo d'erba, uccello o albero può giocare un tiro bizzarro, mutare corso al destino. Sono miracoli che scaturiscono senza meraviglia da una realtà quotidiana concreta e terrestre. Un così schietto amore per le semplici cose della terra trova riscontro nelle illustrazioni tratte da quadri di Bruegel: figure, scene di villaggio, dorati paesaggi, tutto un mondo che è appunto fantastico e terrestre al tempo stesso.
EUR 80.75
-
Introduzione a Cattaneo

Proposta con acritiche esaltazioni o liquidata con cenni precipitosi, la figura di Cattaneo è rimasta per molti anni un «oggetto misterioso», inafferrabile per una sua presunta «proteiformità». Il dibattito del dopoguerra e la stessa ridiscussione della precedente storiografìa idealistica non hanno impedito la diffusione e il consolidamento dell'immagine di Cattaneo «poligrafo». Con questa raccolta di articoli Puccio intende invertire la tendenza e cogliere l'aspetto unitario del pensiero e dell'attività di Cattaneo, sfrondando un gioco intricato di interpretazioni in cui la stessa «attualità» del personaggio è spesso argomento strumentale. Inserendosi fra il vecchio mito che ha voluto Cattaneo «ponte proteso verso la palude» e il nuovo che intende proporcelo come il simbolo dell'efficientismo tecnocratico-borghese, Puccio ci riconsegna le costanti dell'indagine cattaneana mettendo in valore le organiche corrispondenze tra il piano teorico e quello pratico, tra quello normativo e quello operativo. L'espansione mondiale del capitalismo inglese, la storia della borghesia europea, le origini e le peculiarità di quella italiana e il modello di società capitalistica e borghese ipotizzato per l'Italia sono il terreno di ricerca su cui Cattaneo ci ricompare storico, geografo, etnologo ed economista, ma anche e sostanzialmente ideologo: allorché i dati storici e scientifici, e gli stessi strumenti dell'indagine, vengono ricondotti a quell'unico valore, «l'incivilimento», a quel modello culturale di società in cui tutto confluisce acquisendo senso e significato unitari.
EUR 5.89
-
L' arte dell'agricoltura
-
Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. Vol. 1: Il Piemonte.
-
Enciclopedia Einaudi. Vol. 2: Ateo-Ciclo.

Quale significato può avere nel quadro generale della cultura oggi una nuova Enciclopedia? In generale le enciclopedie riflettono un momento o l'altro della vita culturale: quello della perfetta stabilità del sapere, della certezza intellettuale, della convinzione che una vetta è stata raggiunta - e questo è il caso, per esempio, del contesto in cui nasce l'Enciclopedia Treccani: attorno a un gruppo di studiosi convinti che l'idealismo consenta non una ma l'organizzazione del sapere, oppure, sebbene lungo linee differenti, è il caso di altre enciclopedie, come la Britannica o la Sovietica -, e l'altro momento di un sapere mutante, in crisi, come suol dirsi comunemente, di una cultura che si cerca, di una società che vede emergere nuovi valori. È questo il caso del quadro generale in cui nasce l'enciclopedia settecentesca. Ciò premesso, sarà piú facile indicare il senso di questa nostra impresa. L'ultimo mezzo secolo, e con particolare accelerazione gli ultimi venticinque anni, hanno mostrato una notevole tendenza nel panorama della cultura mondiale a rivedere, rimuovere, cambiare. Hanno modificato sostanzialmente le categorie interpretative, il contesto esplicativo, il valore delle interpretazioni, il ruolo dei «fatti». E, ancora, hanno aumentato la divaricazione delle specializzazioni, approfondendo le analisi nei singoli campi dello scibile, ma perdendo di vista le connessioni concettuali, la rete dei legami che rende complesso e vitale il tessuto del sapere. A noi è sembrato che un'enciclopedia debba costituire, oggi, il punto di convergenza di questo vasto sommovimento ed esprimere non già una summa del sapere ma l'intreccio delle strade che la ricerca contemporanea sta seguendo, le strutture organizzative, e - soprattutto - le possibilità del domani. Non una summa , dunque, ma neppure un digest del sapere. Piuttosto, forse non è velleitario mirare a una sorta di individuazione critica dei momenti di incrocio...
Enciclopedia Einaudi. Vol. 3: Città-Cosmologie.

Quale significato può avere nel quadro generale della cultura oggi una nuova Enciclopedia? In generale le enciclopedie riflettono un momento o l'altro della vita culturale: quello della perfetta stabilità del sapere, della certezza intellettuale, della convinzione che una vetta è stata raggiunta - e questo è il caso, per esempio, del contesto in cui nasce l'Enciclopedia Treccani: attorno a un gruppo di studiosi convinti che l'idealismo consenta non una ma l'organizzazione del sapere, oppure, sebbene lungo linee differenti, è il caso di altre enciclopedie, come la Britannica o la Sovietica -, e l'altro momento di un sapere mutante, in crisi, come suol dirsi comunemente, di una cultura che si cerca, di una società che vede emergere nuovi valori. È questo il caso del quadro generale in cui nasce l'enciclopedia settecentesca. Ciò premesso, sarà piú facile indicare il senso di questa nostra impresa. L'ultimo mezzo secolo, e con particolare accelerazione gli ultimi venticinque anni, hanno mostrato una notevole tendenza nel panorama della cultura mondiale a rivedere, rimuovere, cambiare. Hanno modificato sostanzialmente le categorie interpretative, il contesto esplicativo, il valore delle interpretazioni, il ruolo dei «fatti». E, ancora, hanno aumentato la divaricazione delle specializzazioni, approfondendo le analisi nei singoli campi dello scibile, ma perdendo di vista le connessioni concettuali, la rete dei legami che rende complesso e vitale il tessuto del sapere. A noi è sembrato che un'enciclopedia debba costituire, oggi, il punto di convergenza di questo vasto sommovimento ed esprimere non già una summa del sapere ma l'intreccio delle strade che la ricerca contemporanea sta seguendo, le strutture organizzative, e - soprattutto - le possibilità del domani. Non una summa , dunque, ma neppure un digest del sapere. Piuttosto, forse non è velleitario mirare a una sorta di individuazione critica dei momenti di incrocio...
Enciclopedia Einaudi. Vol. 8: Labirinto-Memoria.

Quale significato può avere nel quadro generale della cultura oggi una nuova Enciclopedia? In generale le enciclopedie riflettono un momento o l'altro della vita culturale: quello della perfetta stabilità del sapere, della certezza intellettuale, della convinzione che una vetta è stata raggiunta - e questo è il caso, per esempio, del contesto in cui nasce l'Enciclopedia Treccani: attorno a un gruppo di studiosi convinti che l'idealismo consenta non una ma l'organizzazione del sapere, oppure, sebbene lungo linee differenti, è il caso di altre enciclopedie, come la Britannica o la Sovietica -, e l'altro momento di un sapere mutante, in crisi, come suol dirsi comunemente, di una cultura che si cerca, di una società che vede emergere nuovi valori. È questo il caso del quadro generale in cui nasce l'enciclopedia settecentesca. Ciò premesso, sarà piú facile indicare il senso di questa nostra impresa. L'ultimo mezzo secolo, e con particolare accelerazione gli ultimi venticinque anni, hanno mostrato una notevole tendenza nel panorama della cultura mondiale a rivedere, rimuovere, cambiare. Hanno modificato sostanzialmente le categorie interpretative, il contesto esplicativo, il valore delle interpretazioni, il ruolo dei «fatti». E, ancora, hanno aumentato la divaricazione delle specializzazioni, approfondendo le analisi nei singoli campi dello scibile, ma perdendo di vista le connessioni concettuali, la rete dei legami che rende complesso e vitale il tessuto del sapere. A noi è sembrato che un'enciclopedia debba costituire, oggi, il punto di convergenza di questo vasto sommovimento ed esprimere non già una summa del sapere ma l'intreccio delle strade che la ricerca contemporanea sta seguendo, le strutture organizzative, e - soprattutto - le possibilità del domani. Non una summa , dunque, ma neppure un digest del sapere. Piuttosto, forse non è velleitario mirare a una sorta di individuazione critica dei momenti di incrocio...
Enciclopedia Einaudi. Vol. 12: Ricerca-Socializzazione.

Quale significato può avere nel quadro generale della cultura oggi una nuova Enciclopedia? In generale le enciclopedie riflettono un momento o l'altro della vita culturale: quello della perfetta stabilità del sapere, della certezza intellettuale, della convinzione che una vetta è stata raggiunta - e questo è il caso, per esempio, del contesto in cui nasce l'Enciclopedia Treccani: attorno a un gruppo di studiosi convinti che l'idealismo consenta non una ma l'organizzazione del sapere, oppure, sebbene lungo linee differenti, è il caso di altre enciclopedie, come la Britannica o la Sovietica -, e l'altro momento di un sapere mutante, in crisi, come suol dirsi comunemente, di una cultura che si cerca, di una società che vede emergere nuovi valori. È questo il caso del quadro generale in cui nasce l'enciclopedia settecentesca. Ciò premesso, sarà piú facile indicare il senso di questa nostra impresa. L'ultimo mezzo secolo, e con particolare accelerazione gli ultimi venticinque anni, hanno mostrato una notevole tendenza nel panorama della cultura mondiale a rivedere, rimuovere, cambiare. Hanno modificato sostanzialmente le categorie interpretative, il contesto esplicativo, il valore delle interpretazioni, il ruolo dei «fatti». E, ancora, hanno aumentato la divaricazione delle specializzazioni, approfondendo le analisi nei singoli campi dello scibile, ma perdendo di vista le connessioni concettuali, la rete dei legami che rende complesso e vitale il tessuto del sapere. A noi è sembrato che un'enciclopedia debba costituire, oggi, il punto di convergenza di questo vasto sommovimento ed esprimere non già una summa del sapere ma l'intreccio delle strade che la ricerca contemporanea sta seguendo, le strutture organizzative, e - soprattutto - le possibilità del domani. Non una summa , dunque, ma neppure un digest del sapere. Piuttosto, forse non è velleitario mirare a una sorta di individuazione critica dei momenti di incrocio...
Enciclopedia Einaudi. Vol. 13: Società-Tecnica.

Quale significato può avere nel quadro generale della cultura oggi una nuova Enciclopedia? In generale le enciclopedie riflettono un momento o l'altro della vita culturale: quello della perfetta stabilità del sapere, della certezza intellettuale, della convinzione che una vetta è stata raggiunta - e questo è il caso, per esempio, del contesto in cui nasce l'Enciclopedia Treccani: attorno a un gruppo di studiosi convinti che l'idealismo consenta non una ma l'organizzazione del sapere, oppure, sebbene lungo linee differenti, è il caso di altre enciclopedie, come la Britannica o la Sovietica -, e l'altro momento di un sapere mutante, in crisi, come suol dirsi comunemente, di una cultura che si cerca, di una società che vede emergere nuovi valori. È questo il caso del quadro generale in cui nasce l'enciclopedia settecentesca. Ciò premesso, sarà piú facile indicare il senso di questa nostra impresa. L'ultimo mezzo secolo, e con particolare accelerazione gli ultimi venticinque anni, hanno mostrato una notevole tendenza nel panorama della cultura mondiale a rivedere, rimuovere, cambiare. Hanno modificato sostanzialmente le categorie interpretative, il contesto esplicativo, il valore delle interpretazioni, il ruolo dei «fatti». E, ancora, hanno aumentato la divaricazione delle specializzazioni, approfondendo le analisi nei singoli campi dello scibile, ma perdendo di vista le connessioni concettuali, la rete dei legami che rende complesso e vitale il tessuto del sapere. A noi è sembrato che un'enciclopedia debba costituire, oggi, il punto di convergenza di questo vasto sommovimento ed esprimere non già una summa del sapere ma l'intreccio delle strade che la ricerca contemporanea sta seguendo, le strutture organizzative, e - soprattutto - le possibilità del domani. Non una summa , dunque, ma neppure un digest del sapere. Piuttosto, forse non è velleitario mirare a una sorta di individuazione critica dei momenti di incrocio...
Il mestiere di grafico

La presenza di Albe Steiner nel mondo della progettazione grafica, del design e della produzione visiva è una realtà nota e riconosciuta in tutta la sua importanza. Steiner ha iniziato l'attività nella seconda metà degli anni '30, intensificando il proprio lavoro dopo il conflitto mondiale quando ha collaborato ad un rinnovamento profondo, professionale, culturale e politico, della grafica italiana partecipando da protagonista a esperienze di fondo, quali “Il Politecnico”, e all'elaborazione di periodici e di informazione di partito. Con gli anni '50 e, via via, in seguito, la sua attività si è fatta ancor più ricca e articolata. Collaborazioni al mondo industriale e della produzione, alla trasformazione dell'editoria, alla stampa e, in particolare, a quella politica cui ha offerto una sempre rinnovata capacità di interpretare e visualizzare la conoscenza e la proposta di problemi e di soluzioni che andassero al di là dell'ipotesi informativa per divenire fermento culturale e, ad un tempo, ricerca di metodo di chiarificazione e di partecipazione: questi alcuni dei momenti e delle caratteristiche di fondo del suo impegno. Ad esso si è accompagnata, poi, la consapevolezza, resa operativa, della necessità di un'organizzazione della professionalità e della relativa preparazione e informazione attraverso la scuola, la struttura sindacale e culturale. Egli si poneva così il problema di far sì che il suo settore di attività non rimanesse prigioniero di un'astratta efficienza formale, ma venisse ricondotto ad un più ampio contesto sociale e culturale, e nel confronto con esso continuamente verificato.Parlare di Steiner significa, dunque,riflettere anche sul contesto e, in particolare, sui termini del vasto dibattito intellettuale e politico sviluppatosi in Italia fin dall'immediato dopoguerra.
EUR 32.30
Storia di Roma. Vol. 1: Roma in Italia.

La storia di Roma ha cristallizzato intorno alla forma di una città antica, delle sue istituzioni e poi del suo impero, la più lunga continuità politica che l'Europa abbia mai sperimentato.Il primo volume, Roma in Italia , si apre con un colpo d'occhio sulle condizioni della penisola ancor prima degli inizi del millennio: una geografia storica dell'Italia preromana e protoromana, consentita dalla nuova ricerca archeologica e da una valutazione migliore e piu equilibrata del patrimonio etnografico conservato nella tradizione antica. L'attenzione si concentra poi sul Lazio e sulle vicende che portarono alla fondazione di Roma, considerata anche come il punto d'arrivo di un lungo percorso precedente, e non soltanto come l'inizio di una nuova storia: il costituirsi materiale e culturale di uno spazio «urbano», la produzione, la rete degli scambi, la terra, i rapporti di parentela. E insieme, l'aristocrazia arcaica, le forme di dipendenza, la politica e le prime spinte espansive, le figure dei re. In risalto le relazioni con gli Etruschi, le comunità latine, i Greci del Sud, e i punti forti della cultura cittadina delle origini: l'esperienza magico-religiosa, il sapere giuridico dei pontefici. Infine, dopo la città serviana e gli anni dei Tarquinii, la svolta repubblicana: la «crisi» e le difficoltà del v secolo; le nuove prospettive del IV.
EUR 85.50
Ubu re

Se è vero, come dice Ionesco, che “rinnovare il linguaggio vuol dire rinnovare la concezione, la visione del mondo”, è indubbio che Jarry può essere considerato uno dei padri della rivoluzione teatrale contemporanea. Non stupisce allora che molti studiosi paragonino il 10 dicembre 1896, “prima” dell'Ubu roi al Theatre de L'Oeuvre di Parigi, alla tumultuosa “bataille d'Hernani” che nel 1830 vide lo scontro decisivo tra classicisti e romantici francesi. Il poeta irlandese Yeats, presente all'avvenimento, ebbe la sensazione di assistere alla fine di un'epoca. L'autore di 'Ubu' sfida consapevolmente uno dei sacri canoni dell'arte occidentale, cioè quello che vuole contenuti e forme di un'opera adeguati alla cultura e ai gusti del pubblico cui è destinata. Trasformando un personaggio concepito all'interno di una beffa studentesca nel doppio cinico e mostruoso dell'umanità, o almeno di una faccia dell'umanità, e facendolo senza nessuna strizzata d'occhio, senza nessuna complicità mondana, bensì con una sorta di disarmante immediatezza e una assoluta noncuranza delle buone maniere teatrali, Jarry mette a segno una provocazione che ha nel famosissimo 'merdre' iniziale il suo emblema definitivo. Il testo - primo di una serie in cui torna la maschera di Ubu - fonde la lignea e meccanica essenzialità del teatro dei burattini con le più torbide e viscerali meschinità umane: cupidigia, egoismo, crudeltà, frode, vigliaccheria… Una fusione che conferisce all'opera e ai personaggi un'insolita dimensione epica alla rovescia.
EUR 9.50
Il bisonte bianco

I nostri anni stentano a produrre miti di significativa grandezza, ma ne fanno un grande consumo. Tra i luoghi mitici, recenti ma indispensabili, c'è il West americano, dove tutte le avventure ridiventano possibili e dove sembrano trovare una spettacolare reincarnazione temi classici quali quelli dell'eroe, della vergine e della bestia. Animale mitico per eccellenza è il bisonte, moderno Minotauro delle praterie… Questa onnipresenza del mito, oggetto della continua e libera riscrittura che ne fanno la fantasia, la letteratura e il cinema, trova un corrispettivo nella originale struttura di questo libro, che è al tempo stesso una rivisitazione storica, una piccola enciclopedia fitta di dati e di informazioni, una reverie affettuosa, un romanzo che corre al galoppo, una ballata popolare, un teatrino dei pupi. Alla caccia di un favoleggiato Bisonte Bianco, imprendibile divinità muschiata dall'occhio maligno, ritroviamo infatti scrittori che sono appartenuti alla realtà storica (l'io narrante dice di chiamarsi Isacco Babel, e presto compare Hermann Melville), personaggi cinematografici (Shane, il cavaliere della valle solitaria che fu interpretato da Alan Ladd), figure leggendarie della Frontiera (Calamity Jane, David Crockett, Buffalo Bill, Custer, Geronimo, i pellerossa e i cowboy): insomma quella folla composita, più fittizia che reale, e tuttavia viva e vitale, che ad ogni impiego fantastico, anche arbitrario, sembra radicarsi ancora più profondamente nell'immaginario collettivo. Se il Bisonte Bianco, come il Minotauro e la Balena di Melville, rappresentano il mistero di quel che è diverso ed estraneo, un piacere combinatorio spinge l'autore a mescolare il documento e la finzione, il gioco e il sogno, la nostalgia dei grandi spazi e la consapevolezza di quanto di iperbolico e di segretamente elusivo si nasconda in ogni epica.
EUR 5.81
Letteratura italiana. Storia e geografia. Vol. 3: L'Età contemporanea.
Fiabe irlandesi
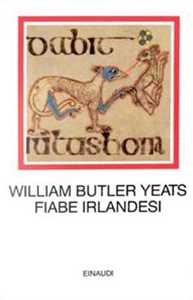
Il “piccolo popolo” dei folletti, esseri alti una spanna che fanno burle e dispetti e possono rapire bambini dalla culla sostituendoli con i loro rampolli grinzosi come vecchi decrepiti; i leprecani, gnomi calzolai che fabbricano le scarpe per le danze delle fate; le sirene che escono dal mare per pettinarsi e allora si possono catturare, basta rubar loro il cappello rosso a tre punte; i giganti dalla barba di pietra che si salda alla roccia delle scogliere; i cadaveri insepolti che s'aggrappano alle spalle dei vivi e si fanno trasportare fino a che non gli si scava un tomba… Il folklore irlandese è gremito d'una folla di presenze soprannaturali che discendono in linea diretta dall'antico paganesimo celtico e che si mescolano coi diavoli e coi santi delle leggende cristiane in una continuità fantastica atemporale, radicata ai prati e alle pietre della verde isola indomabile.W.B. Yeats che è stato, oltre che uno dei grandi poeti del nostro secolo, anche un accanito cultore delle tradizioni irlandesi e un polemico rivendicatore dell'immaginazione magica nel cuore della nostra civiltà meccanica, ha dedicato ai racconti popolari della sua terra un prolungato lavoro di ricercatore, di trascrittore, d'antologizzatore, d'editore. Il corpus delle sue raccolte folkloristiche ha due qualità fondamentali che gli danno spicco tra tutti i libri del genere: 1) la scrittura piena di vivacità e di calore e di poesia, sia che racconti un semplice episodio di apparizione paurosa, una credenza locale bizzarra o un'elaborata vicenda visionaria e incantata, cosicché la lettura risulta sempre varia e trova spunti di divertimento a ogni pagina; 2) un'applicazione classificatoria e sistematica che permette a Yeats di mettere ordine in questa proliferazioe fantastica tra le più aggrovigliate e ridondanti e di farci da guida con mano sapiente e discreta. (Italo Calvino)
EUR...